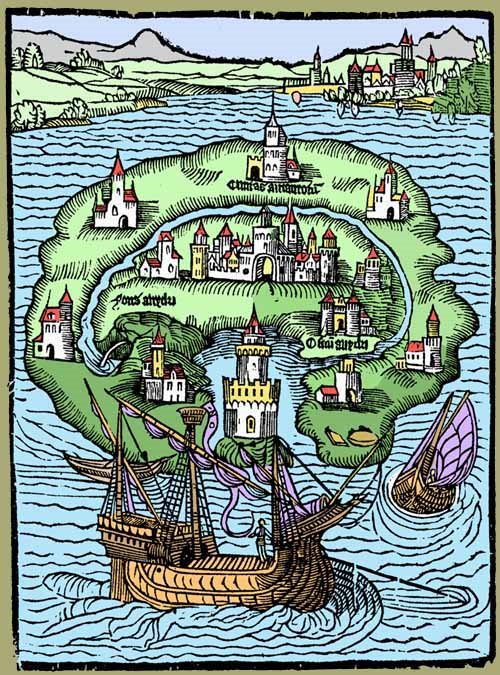Beati gli umili perché succederà loro qualcosa di bello che ora non ricordo.
Lo diceva uno della Trinità divina cattolica, non so più bene chi dei tre, perché dalle mie ecclesistiche frequentazioni
è passato un po' di tempo e
non sono ferratissima in Teologia, ma mi pare comunque di ricordare che fossero tutti e tre uno solo, quindi come citazione direi che va bene.
Il fatto è che quando sentivo ste parole a messa o le leggevo su qualche libretto che mi veniva propinato al catechismo mi dicevo che non fosse una grande idea, che ad essere umili non si arriva da nessuna parte.
Poi, con il passare del tempo, l'imbiancare dei capelli, l'inflaccidirsi della pelle, ho iniziato a pensare che invece quello della Trinità ne sapesse una più del diavolo.
Infatti, se uno ci pensa, umile è diverso da umiliato.
L'
umile è colui che esercita
umiltà, in modo che definirei riflessivo. Umile è chi guarda se stesso senza presunzione e preconcetti, cerca di capire in primis se ha sbagliato, e poi se essere orgogliosi sia veramente la soluzione più efficiente ed efficace. Se uno decide di umiliarsi, lo fa con consapevolezza. Se uno decide di umiliarsi, già non si sente così minacciato da ciò che sta facendo.
E' un po' come quando si prende una storta. Si può reagire accompagnandola, oppure opponendovi resistenza orgogliosa. Nel primo caso non ci si fa tantissimo male, quindi si reagisce in modo efficiente ed efficace. Nel secondo, si rischia di farsi malissimo e di prendersi una distorsione o peggio di spaccarsi i legamenti, con conseguente lievitazione della caviglia fino ad avere un palloncino al posto del'articolazione. Un palloncino gonfiato.
L'umile consapevole è uno che capisce che
è più strategico piegarsi come una canna piuttosto che stare rigidi come una quercia a farsi spezzare i rami o peggio il tronco dall'uragano. Tanto sa che poi si ridrizzerà.
L'
umiliato, invece, è colui che subisce un'
umiliazione. Qui non c'è nulla di riflessivo, c'è qualcuno che compie un'azione verso qualcun altro. E l'azione è quella di affossamento.
Lì sì che è brutto.
A volte.
Non sempre, però.
Se l'umiliato riesce ad assecondare l'umiliante, poi può riprenderlo e ritorcere la sua azione contro di lui. Un po' come insegnano al corso di autodifesa. Prendi l'umiliante, lo spiazzi accompagnando l'attacco, e poi gli sbatti addosso una bella umiltà potente ed efficace. Sarà facile vederlo stramazzare al suolo.
Umile umiliazione, come quando a calcio ti arriva addosso un energumeno di centicinquanta chili e affonda con tutta la sua possenza sulla tua caviglia. Se opponi resistenza sei fritto. Ti squarcia caviglia crociato menisco e chi più ne ha più ne metta. Immobilità nervoso ortopedici incazzatura operazioni frustrazione riabilitazione appallamento. Grande umiliazione con umilianti ripercussioni sull'orgoglio oppositivo con cui si era deciso che una caviglia fatta d'ossa tendini sangue e carne potesse resistere all'impeto di un quintale e mezzo tacchettodotato.
Nel film "
Mister Chocolat", il protagonista è un esempio di
umiliata umiltà, che di solito non dovrebbe esistere, perché alla fin fine l'umiltà non è mai umiliata, anzi è una roba da figo, da persona che non si caga in mano a mollare un attimo le redini e a perdere il controllo perché sa di avere la padronanza di poterlo mantenere, di recuperarlo in volo o al balzo dopo un po'.
E' una roba da chi, quando si accorge che sta sbagliando o ha sbagliato, corregge il tiro dopo aver detto "Ok, sto sbagliando/ho sbagliato".
Poi risbaglia, e lo ricapisce, ririsbaglia e lo riricapisce ancora, avanti così.
Alla fine muore.
Va beh, finale triste, ma mica possono vivere tutti sempre felici e contenti, e per sempre.
Sarebbe pure noioso.
Tornando al nostro Chocolat, lui non voleva essere umiliato, eppure all'inizio accettava di esserlo, per gioco. Teneva presente che scena è una finzione. E all'inizio era furbescamente umile.
Fare il selvaggio mi fa guadagnare? E io lo faccio.
Fare quello che riceve calci nel sedere mi fa guadagnare? E io lo faccio.
Poi il tempo passa (e i capelli imbiancano, e la pelle si inflaccidisce, eccetera eccetera) e uno perde l'abilità di prendersi un po' in giro, bonariamente.
Uno perde la
fanciullesca capacità di ridere di se stesso e di vedersi dall'alto, con
leggerezza.
Tutto diventa pesante, anche la finzione, anche ciò che ci dà da vivere, e da vivere alla grande.
Uno si arrovella su principi che orgogliosamente porta avanti diventando cieco a ciò che è meglio, a ciò che gli conviene, e a volte perfino a ciò che è.
Con pesantezza si gioca tutto, ma la pesantezza, si sa,
è difficile da sostenere,
e infatti non si sostiene,
e si precipita giù trascinati dal proprio orgoglio,
dalla propria pesantezza,
giù fino alla rovina definitiva.
L'
umiliata umiltà di Chocolat è un ossimoro in termini, fa cadere dalle stelle non riconosciute alle stalle, ben identificate quando ormai è troppo tardi.
Meglio umiliarsi.
E' meno umiliante.